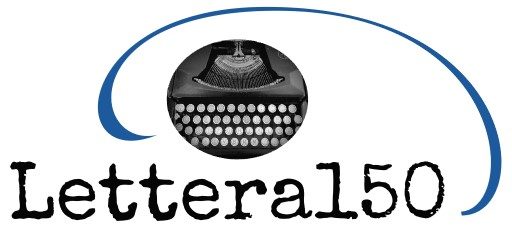Riccardo Cardilli (Università di Roma Tor Vergata)
Luigi Garofalo (Università di Padova)
Vincenzo Mannino (Università Roma Tre)
Il prof. Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito, ha annunciato una riforma delle linee-guida per l’insegnamento delle varie discipline nella scuola. Tra l’altro, ha annunciato di voler reinserire il latino nel curricolo degli ultimi due anni della scuola media e di ridefinire l’insegnamento della storia, prestando un’attenzione specifica alla storia d’Italia, dell’Europa e dell’Occidente.
Concentrandoci sulla storia, osserviamo come molto spesso non sia soltanto il passato a illuminare il presente, ma sia il presente che di colpo ci fa guardare a un evento passato con innovativa prospettiva. La storia non è una scienza statica, immobile, noiosa: al contrario, è stimolante, plurale, arricchente, con la sua capacità di gettare luce sul presente. Consente di rivelare intere verità che talvolta scompaiono, sostituendosi con immaginarie ricostruzioni ideologicamente caratterizzate. Quel che conta è acquisire una sensibilità storica capace di relativizzare e di consentire la decodificazione critica delle idee e dei fatti. Basta pensare come il calcolo del tempo sia stato e sia determinato in modo vario presso le diverse civiltà.
La storia è una continua rigenerazione di se stessa. È sbagliato rafforzare nella formazione delle nuove generazioni la sensibilità per la (e non solo la conoscenza della) storia?
Quello di Valditara è un nostalgico amarcord? Non lo crediamo. Riteniamo invece che con la rinnovata attenzione per lo studio della storia si voglia aprire una promettente stagione di approfondimento della nostra identità, senza negazionismi, con importanti riflessi sui complessi profili della integrazione.
La sensibilità per la storia non significa solo accedere a una più o meno ampia conoscenza degli avvenimenti storici, ma aiuta ad acquisire la consapevolezza delle proprie tradizioni, dell’origine e dello sviluppo della propria lingua, delle proprie radici culturali, ad avere la memoria di sé, delle relazioni con un determinato territorio. Questa consapevolezza dà sostanza all’identità individuale e collettiva di un certo contesto. Consente l’avvio su basi solide del confronto, rendendo evidenti i presupposti per la proficua integrazione delle persone che quotidianamente si spostano in cerca di nuovi luoghi dove vivere. La storia – a cominciare da quella dell’antica Roma, segnata dalla integrazione sulla base dei forti valori espressi dalla sua civiltà – ci insegna che l’integrazione necessita della volontà di integrarsi, ma, soprattutto, della capacità in chi vive nella realtà ospitante di farsi riconoscere per la propria identità e di rendere partecipi di essa i nuovi arrivati. Altrimenti si crea una società pericolosamente priva di coesione. L’integrazione politica non può prescindere dall’integrazione culturale e le istituzioni possono raggiungere un buon equilibrio solo se in armonia con la storia di un territorio.
Far studiare la storia, affinando la sensibilità storica delle nuove generazioni, è far cogliere con spirito critico il significato delle idee e dei fatti in tutta la loro complessità. Ci sentiamo di affermarlo proprio come storici e giuristi.
D’altro canto, proprio la non omologazione delle differenze culturali, religiose e linguistiche impone un senso di identità che non si costruisce con i proclami da propaganda, ma attraverso un processo che innervi nella formazione delle nuove generazioni anche il senso critico per la storia. Lo sforzo di Valditara per dare corpo nella scuola a questa necessità va appoggiato, ben al di là del quotidiano e logorante dibattito politico, che preferisce di sovente l’immobilismo, perché in fin dei conti chi non fa non sbaglia mai …”