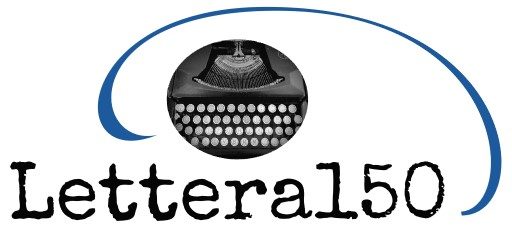Domenico Rossi
Premessa
Per esaminare un problema complesso quale quello della Difesa Europea comune appare lecito porsi preliminarmente una domanda. In un mondo globalizzato quale quello attuale è riuscita l’Europa a ritagliarsi un ruolo forte e politico di diplomazia internazionale oppure ha ricoperto e ricopre un ruolo ancillare e subalterno? Non credo purtroppo che vi siano dubbi a riguardo!
Sulle motivazioni di questo ruolo secondario, in specie in tema di sicurezza, ha certamente influito la sottovalutazione compiuta a suo tempo sugli effetti della dissoluzione della Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e sulla conseguente scomparsa del “Patto di Varsavia”. Non si giudicò infatti che vi potesse essere più una reale contrapposizione ai principi e valori occidentali, almeno in Europa, né una reale consistente contrapposizione armata alla NATO. Una sottovalutazione estesa anche alla conflittualità limitata ma forte e violenta che emerse in diversi paesi, frutto di antichi rancori mai sopiti tra popoli di etnie e religioni diverse e che solo un regime dittatoriale (vds territori della ex- Jugoslavia) era riuscita a mantenere a basso livello. Né tanto meno venne dato il giusto peso al percorso della nuova Federazione Russa capace invece di riarmarsi, riconquistare influenza geopolitica ed espandersi anche verso altri Continenti come l’Africa. Fu in sintesi ritenuto sufficiente affrontare le varie situazioni attraverso Missioni ONU, NATO o Europee (le cosiddette “Missioni di pace”) peraltro con un utilizzo proporzionato e selezionato delle armi, dei mezzi e degli uomini, senza cioè ritenere invece necessaria la concreta realizzazione di una Forza Militare Europea che fosse espressione della volontà non solo di una Difesa comune ma anche di autonome scelte geopolitiche, strategiche e d’intervento.
Solo, le recenti guerre in Ucraina e in Medioriente, le tensioni nel mar Rosso con riflessi diretti e incidenti sul traffico commerciale e quindi sugli interessi economici dei singoli Paesi, il possibile disimpegno degli Stati Uniti verso l’Europa ovvero il loro sempre maggiore interesse verso l’est-asiatico e la minaccia cinese hanno spinto l’Unione Europea a riconsiderare i propri sistemi e meccanismi di difesa, in funzione di una nuova percezione della guerra come evento molto più prossimo e destabilizzante ovvero come fenomeno di disequilibrio e di incertezza globale.
Un po’ di Storia
Il progetto di una difesa comune europea ,senza ricordare tentativi ben più lontani, ha in realtà la sua origine nel Trattato dell’Unione Europea (Trattato di Maastricht) del 1992 e nella dichiarazione di Saint-Malo del 1998,che hanno come risultato finale la nascita della Politica Estera di Sicurezza e Difesa (PESD).Il successivo passo fu, nel 2001, il Trattato di Nizza, che sancì la costituzione sia del Comitato per la Politica e Sicurezza europea, composto dai rappresentanti dei Paesi membri, sia del Comitato Militare dell’Unione Europea (EUMC), massimo organismo militare composto dai Capi di Stato Maggiore delle Forze Armate dei Paesi europei, nonché dello Stato Maggiore dell’Unione Europea (EUMS). Infine, nel 2009, il Trattato di Lisbona sancì ufficialmente la nascita di una comune politica di Sicurezza e Difesa Europea, che, a partire dal 2021, fu dotata di un supporto economico dedicato, il Fondo Europeo di Difesa (EDF), con un budget predefinito per supportare le ricerche e gli sviluppi nell’ambito della difesa congiunta europea, e promuovere una base industriale di difesa innovativa e competitiva. Il quadro sopra indicato però ,pur se ha portato alla realizzazione di qualche progetto comune, non può che considerarsi sotto un punto di vista di concretezza operativa ovvero di difesa reale fallimentare. Ne sono dimostrazione i gruppi tattici («battlegroups») di 1.500 militari creati nel 2007 che ,nonostante le varie missioni, non sono mai stati impiegati in Teatro Operativo. Una situazione dovuta soprattutto alla previsione di dovere prendere decisioni “all’unanimità” con assoluta mancanza di flessibilità e con la conseguente incidenza negativa sulla necessaria rapidità del processo decisionale di impiego delle forze disponibili.
Situazione attuale
La svolta apparentemente concreta è avvenuta nel 2022 allorché, dopo l’invasione della Ucraina da parte della Federazione Russa, il Consiglio Europeo ha approvato un documento, che detta una nuova linea d’azione, intitolato «Una bussola strategica per la sicurezza e la difesa. Per un’Unione Europea che protegge i suoi cittadini, i suoi valori e i suoi interessi e contribuisce alla pace e alla sicurezza internazionali”. Gli Stati membri si sono infatti impegnati a sviluppare e rafforzare entro il primo trimestre del 2023 le missioni civili, così da essere in grado di schierare una missione con 200 esperti civili entro 30 giorni anche in ambienti complessi, nonché a raggiungere entro il 2025 una capacità di dispiegamento rapido di una forza massima di 5000 militari, con forte autonomia ovvero comprensiva di componenti terrestri, aeree e marittime, e dei necessari elementi logistici strategici. Una forza organizzata in gruppi tattici con “capacità militari degli Stati membri individuate in precedenza” da utilizzare non solo nel quadro di esigenze dell’Unione Europea, ma anche di quelle “nazionali come pure in contesti diversi, quali l’ONU e la NATO».
Si conferisce inoltre la necessaria flessibilità al processo decisionale prevedendo che, ove vi siano implicazioni nel settore militare o della difesa, si possa procedere non solo con decisioni all’unanimità, secondo la regola generale, ma anche ricorrendo all’istituto “dell’astensione costruttiva” o attraverso una “cooperazione rafforzata”, al fine di consentire anche a un solo gruppo di Stati membri, disposti e capaci, di pianificare e condurre una missione“ un’operazione nel quadro dell’UE e sotto la supervisione politica del Consiglio». Contestualmente viene deciso di rafforzare il complesso delle strutture di comando e controllo per potere essere «pienamente in grado di pianificare, controllare e comandare compiti e operazioni esecutivi e non esecutivi, nonché esercitazioni reali”.
Conclusioni
“La bussola strategica” del 2022 ha finalmente preso atto dei limiti della politica di sicurezza e difesa comune, ammettendo che «l’Unione Europea è collettivamente poco attrezzata per contrastare l’intera gamma di minacce e sfide che si trova ad affrontare». Peraltro nonostante il 2025 sia stato individuato come l’anno in cui le forze di dispiegamento dell’Ue sarebbero diventate operative l’obiettivo, seppure minimale, appare ancora lontano dall’essere raggiunto. Sicuramente sono stati compiuti primi passi concreti e rimane la positività dell’avere individuato la rotta da seguire una nuova essenziale linea d’azione. Occorre ora continuare con maggiore fermezza specie a fronte di una situazione internazionale che rende sempre più necessario per l’Unione Europea un ruolo effettivo e concreto, che faccia perno anche su una autonoma capacità di Difesa e di intervento, per tutelare i propri interessi strategici di qualsiasi natura.