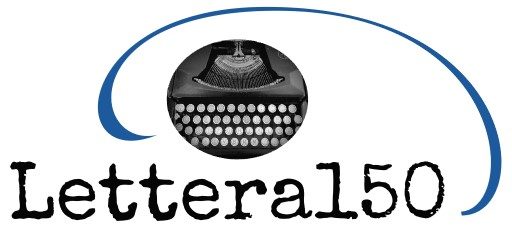Contro le false certezze dei totalitarismi
Giuseppe Parlato, Professore emerito dalla Università Internazionale di Roma (Unint)
Il 30 marzo 2004, il Parlamento approvava una importante legge che istituiva il “Giorno del Ricordo” , al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia delle foibe e del successivo esodo istriano, giuliano, fiumano e dalmata.
La legge fu approvata con il quasi unanime consenso delle forze politiche, salvo Rifondazione comunista, i Comunisti italiani e alcuni del gruppo misto. Fu il grande successo di entrambe le parti, destra e sinistra, che non vollero presentare la legge come divisiva: si segnalarono da un lato Fini e Menia e dall’altro Fassino e, soprattutto, Violante che riuscirono a superare le perplessità ideologiche della sinistra. Alcuni, come D’Alema, Bersani e Bertinotti, non parteciparono al voto.
La stragrande maggioranza del Parlamento comprese che non si trattava di una “vendetta dei fascisti”, come qualcuno aveva sostenuto motivando il voto contrario ma della necessaria riparazione istituzionale a decenni di silenzio sul tema.
Il silenzio iniziò subito: i governi Bonomi, Parri e De Gasperi erano perfettamente al corrente del dramma delle foibe fin dai primi del 1944, e cioè subito dopo la prima – per fortuna breve – manifestazione della violenza dei partigiani e dei militari titini del settembre-ottobre 1943.
Così come lo era evidentemente il Partito Comunista, il quale, fino al 1948, con la rottura tra Stalin e Tito, appoggiava la politica jugoslava, giungendo a chiedere alle popolazioni del Friuli e della Venezia Giulia di accogliere fraternamente le truppe del IX Corpus jugoslavo, le quali avrebbero permesso, insieme con la liberazione dell’Istria, anche quella dell’Italia settentrionale.
Quando poi Tito ruppe con Stalin, altre ragioni si opposero al chiarimento delle situazioni di quegli anni: Tito era diventato improvvisamente “amico” degli Stati Uniti, che pensavano di utilizzarlo per aprire una falla nel Patto di Varsavia, cosa che invece non avvenne. In questo modo, la difesa di Trieste italiana divenne sempre più fragile: i governi, salvo quello di Pella, se ne disinteressarono, comprendendo che l’affare era in mano delle sole capitali che contavano (Londra, Parigi, Washington e Mosca) e che il ruolo dell’Italia, già debole per la sconfitta, diventava irrilevante.
Fu necessario attendere il 1954 per riavere Trieste in Italia, perdendo però contemporaneamente tutta la “zona B”, già di fatto sotto il governo di Belgrado.
I governi italiani non si preoccuparono di sottolineare che la divisione tra zona A e zona B non riguardava la sovranità dei territori ma la loro amministrazione: per cui se Belgrado fra il 1947 e il 1954 aveva introdotto nella zona B la lingua obbligatoria, la moneta, le norme giuridiche del resto della Jugoslavia, sistema dittatoriale compreso, l’Italia non sollevò mai nelle sedi appropriate queste palesi violazioni delle norme fissate a Parigi nel 1947.
Se ci fu un esodo così significativo (sai 300 ai 350 mila esuli) e così lungo (dal 1943 fino al 1975, trattato di Osimo) ciò dipese dalla impossibilità della vita libera in Jugoslavia. Dopo il pericolo e il terrore delle foibe, anche le pesanti condizioni di vita della minoranza italiana in Jugoslavia costituirono le cause dell’esodo.
Senza poi parlare di come gli esuli vennero accolti in Italia: spesso come “fascisti” che sfuggivano alla sacrosanta “giustizia” jugoslava per i molti delitti loro attribuiti dalla polizia segreta di Tito, l’Ozna.
Di tutto questo non si parlò in Italia per molto tempo e tutti, o quasi, furono d’accordo. Rimase questa una pagina strappata della storia italiana, mai conosciuta dalla opinione pubblica, dagli studenti a scuola, nelle università. Troppi erano stati gli errori e le accondiscendenze per potere affrontare, anche a livello storico, un tema così scottante.
Soltanto con la caduta del muro di Berlino, alla fine del 1989, si incominciò a parlare di foibe e, meno, di esodo. Negli anni immediatamente successivi ci si scontrò con chi affermava che le foibe non erano mai esistite o, se erano esistite, erano piene di animali o di cadaveri di tedeschi o di fascisti.
Per tutti questi motivi il Giorno del Ricordo fu assolutamente necessario. Oggi, in qualche modo, gli studenti sanno che cosa sono state le foibe, che c’è stato un esodo, che i profughi istriani, giuliani fiumani e dalmati fuggivano dalle terre nelle quali le loro famiglie erano vissute per secoli solo per potere restare italiani.
Certo, anche oggi i negazionisti e i “giustificazionisti” non mancano. Alimentati dai social che fanno credere che esista una effettiva fetta di opinione pubblica ancora convinta che le foibe siano state un’invenzione di chissà quali “fascisti”, in realtà i nostalgici di Tito sono poca cosa, meno ancora, in percentuale, dei voti contrari in Parlamento alla legge del Ricordo.
Questo significa che la strada intrapresa è quella giusta, anche quando qualcuno sente la necessità di imbrattare le lapidi che ricordano Norma Cossetto o quelle poste all’interno dei perimetri dei luoghi degli infoibamenti. Se non riescono a trovare altri argomenti da contrapporre all’analisi storica, ciò significa che in questi ventuno anni si è fatto un buon lavoro e che questa della discussione e non della contrapposizione è la strada giusta, necessaria, indispensabile, come hanno dimostrato gli incontri del Presidente Mattarella con i capi delle repubbliche slovena a croata e anche la recentissima manifestazione per Gorizia e Nova Goriza capitali della cultura 2025.
Le Linee Guida che il Ministero dell’Istruzione e del Merito nel 2023 ha posto a disposizione dei docenti dei vari ordini di scuola hanno contribuito a moltiplicare i corsi estivi, quelli regionali e quelli nazionali e hanno sviluppato nuovi interessi sul tema, così come li stano sviluppando i viaggi nei luoghi delle foibe e dell’esodo che il MIM sta promuovendo.
Si dimostrerà, in questo modo, che la cultura – se seriamente intesa – è in grado di smontare le false certezze dei totalitarismi, in quanto veri responsabili dei massacri del Novecento, quando, alla ricerca della società perfetta si sacrificavano centinaia di migliaia di “nemici del popolo”, non solo in Italia ma in tutta Europa.