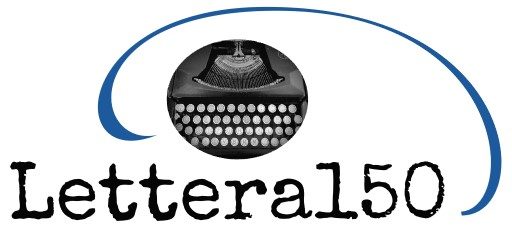Anna Daniela Savino, assegnista di ricerca in pedagogia presso l’ Università degli Studi di Bari Aldo Moro
E’ affascinante riflettere su quante siano le interconnessioni che possono giungere alla mente che vuol pensare, alla mente critica, quando ci si sofferma sull’oggetto-concetto del “velo”.
Esso richiama molteplici sfumature di riferimenti poetici, onirici, filosofici. E incredibilmente mette insieme l’Oriente con l’Occidente, proprio a partire dalla sapienza filosofica. Si pensi alla suggestiva immagine del Velo di Maya, ripresa da Arthur Schopenhauer ne Il mondo come volontà e Rappresentazione, per indicare il lavoro della conoscenza, dell’accesso all’essere delle cose.
Soffermiamoci un attimo sul livello ontologico della questione, il livello dell’essere che il “velo” porta alla mente; nella storia del pensiero e della filosofia occidentale, il primo concetto che ha a che fare con il velo è il concetto greco classico di verità: Martin Heidegger -in Essere e Tempo– riprende nella sua radice etimologica greca antica lo stesso concetto di verità, l’a-lethèia, come dis-velamento. La conoscenza della verità implica un lavoro, uno scoprire, implica il non-nascondimento delle cose. Si può conoscere nella sua verità ciò che viene portato alla luce e dis-velato.
Il livello ontologico, allora, è profondamente intrecciato a quello gnoseologico, della conoscenza. Ma non solo. Nel “mito della caverna” -sempre Martin Heidegger ne parla riflettendo sulla dottrina di Platone della verità- il dis-velamento, l’essere delle cose e il livello conoscitivo hanno immediatamente a che fare con gli uomini, con il rapporto tra gli uomini. Non soltanto si vuol conoscere la verità delle cose, di tutto ciò che ci circonda; se ci pensiamo bene il primo oggetto di mio interesse che vorrei conoscere nella sua verità è l’Altro da me. Si tratta di un livello originario, radicale, primariamente ontologico ma un istante dopo gnoseologico ed etico.
Paul Ricoeur -nell’opera Alla scoperta della fragilità- ci dice: “Un altro, contando su di me, mi rende responsabile dei miei atti”.
E’ quasi un’evocazione dal profondo di quello che chiamiamo “presenza”. La presenza dell’Altro affianco, davanti a me. Essa mi incuriosisce e mi inquieta allo stesso tempo. Mi interroga e mi attira, in qualche modo mi rassicura e contemporaneamente mi impaurisce. E’ come me, mi somiglia eppure è così profondamente diverso, differente da me.
Si tratta dell’incredibile e imprescindibile intreccio dell’identità e dell’alterità che accade un istante “prima” della cultura, delle diversità delle tradizioni storiche.
E si gioca al livello dell’essere, innanzitutto, il rapporto identità-alterità, che da un lato precede ogni altra categorizzazione, filosofico-culturale, dall’altro ci si mostra effettivamente nella storia incarnata, contingente; quindi tocca il livello della conoscenza e del rapporto tra gli esseri umani. Probabilmente sarebbe giusto, cioè più aderente all’emergere della sostanza dell’essere dell’umanità, cogliere quel primo istante originario che si palesa come “atemporale”: la propria identità e quella altrui sono intimamente e originariamente legate, il proprio essere si coglie nel guardare l’Altro, nel rapporto con l’Altro, l’Identità emerge nella e dall’Alterità. Nel riconoscimento della “presenza” visibile dell’Altro difronte a me. Ed è proprio questo ciò che genera e può generare l’essenza morale, la responsabilità.
Ecco che allora i tre livelli del discorso filosofico, che percorrono tutta la storia del pensiero occidentale -livello ontologico, gnoseologico ed etico – nel dis-velamento e nel concetto greco di a-letheia si incontrano e si intrecciano l’uno con l’altro.
La scoperta dell’identità-alterità, implica da una parte il non-nascondimento e dall’altra la relazione, dunque.
Nella Fenomenologia dello spirito Hegel, attraverso le celebri figure, potentemente dipinge questo intreccio, questo reciproco guardarsi di tutti gli uomini proprio per “riconoscersi” e mettere a tema i propri rapporti, che possono essere rapporti di potere come il “servo-padrone”.
Lacan parla dello “stadio dello specchio”: ad un certo punto del suo sviluppo, il bambino scopre “lo specchio” in cui guarda sé stesso. Lì, secondo l’autore accade la divisione del soggetto, il soggetto non si riconosce nell’immagine che vede, ma questa potrebbe essere una questione secondaria su cui riflettere ed eventualmente anche dissentire. L’atto primario è la possibilità che il soggetto ha di guardarsi, di “vedersi” ed eventualmente conoscersi: in questo accade il mirabile evento della scoperta di ciascuno per cui la prima Alterità, appunto, con cui ho a che fare è proprio la mia stessa Identità.
Levinàs in Totalità e Infinito, afferma: “Noi chiamiamo etica una relazione tra due termini dove l’uno e l’altro non sono uniti né per una sintesi dell’intelletto, né per la relazione da soggetto a oggetto, e dove tuttavia l’uno giova o importa o è significante all’altro”, ossia l’Altro che incontro può assumere un significato nella mia vita. E di questa potenza significante che l’altro ha nel mio destino non mi posso liberare.
L’Altro esiste, come esisto io, e mi si pone innanzi. Il mio primo atto di riconoscimento dell’Altro passa, allora, attraverso lo sguardo, il guardare, che implica il conoscere e la relazione.
Ed ecco il punto: come posso conoscere chi sfugge al mio sguardo? Come posso incontrare e comprendere, financo ad amare chi si nasconde al mio sguardo?
La scuola, luogo dell’insegnamento in cui di indica di guardare per conoscere, è anche luogo per eccellenza di relazione. E’ qui che accade, l’imprescindibile intreccio e incontro delle identità e delle alterità, in formazione.
E’ la nostra scuola, il nostro luogo primario in cui si origina il sapere, il guardare le cose, gli oggetti culturali delle discipline assieme alle persone che abitano e costituiscono la scuola stessa, è in questo luogo che si generano di fatto le nostre primissime relazioni affettive e sociali, proprio nello stesso luogo in cui si impara il dis-velamento.
La relazionalità, seguendo il filo del discorso filosofico che parte dai concetti di verità, essere e conoscenza fino a giungere al poter cogliere il significato delle cose e dei rapporti, non può prescindere dallo sguardo. Ogni velo, copre e nasconde. Il velo implica il voler nascondere, il voler coprire facendo come se non ci fosse, ciò che invece c’è ed esiste con la sua presenza, dietro, sotto.
Fino alla cancellazione violenta di ciò che continua di converso ad esistere.
E’ un non-riconoscimento di ciò che vi si para dietro. E’ un ostacolo al vedere, allo sguardo e quindi alla relazione, al rapporto.
Ciò che impedisce lo sguardo, ciò che vela invece di dis-svelare, ciò che impedisce il guardare, il poter vedere e il poter essere visti, il riconoscere e l’essere riconosciuti nella propria presenza, a scuola che è luogo del vedere e del conoscere, luogo dell’essere in relazione e del rapporto, luogo della socialità e dell’integrazione culturale, luogo dell’incontro del dialogo, luogo del confronto aperto tra generazioni, a scuola ciò che vela e oscura invece di schiarire, a meno che non si voglia essere profondamente paradossali, semplicemente non dovrebbe esserci.
Perché accada e si insegni, a scuola, anche il respondeo, che ha a che fare con il respectum, ancora con il vedere l’altro, quindi perché accada la responsabilità occorre che l’altro non nasconda il suo volto.
Volto, che, comunque e sempre, anche per chi decide di nasconderlo con il velo del niqab, continuerà sempre ad esserci, poiché, afferma Levinàs ogni “volto mi chiede e mi ordina” sempre, anche se ci ostina, coprendolo, a pensare di non farlo essere.