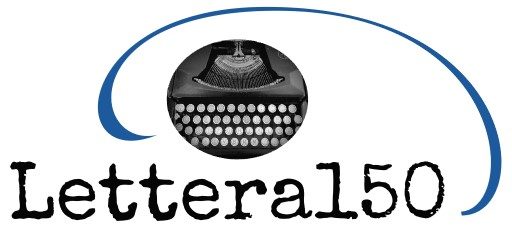Alfonso Badini Confalonieri
Ormai da tempo gli operatori del diritto devono constatare il progressivo deterioramento della qualità dei testi normativi, i cui effetti negativi sono spesso percepiti da imprese e cittadini.
La crescente quantità delle norme, la pessima qualità del loro lessico e i difetti nel loro coordinamento pregiudicano seriamente il principio fondamentale della certezza del diritto, che è la base di ogni convivenza civile e di un ordinamento democratico, il baluardo contro l’arbitrio del potente o anche solo del burocrate di turno.
La scarsa qualità delle leggi si manifesta anche nella mancata ponderazione degli effetti della norma: spesso vengono emanate disposizioni mosse da esigenze estemporanee, quali il clamore mediatico di fatti di cronaca, e magari da ideali di per sé condivisibili, quali la tutela di determinate categorie di cittadini, senza considerare gli interessi di altre categorie e i “costi” (non solo economici) per il sistema.
Non è necessario richiamare le più raffinate teorie dell’analisi economica del diritto (ad esempio gli scritti di Francesco Denozza, per citare un nostro connazionale). Possiamo qui limitarci ad osservare che ogni ideale o intento, anche il più nobile e sacrosanto, può essere tradotto in regola nei modi più vari e con effetti che possono giungere addirittura a tradire l’intento originario (la c.d. eterogenesi dei fini).
È vero che ogni norma è espressione di scelte politiche del legislatore e che tali scelte comportano sempre la preferenza di taluni interessi rispetto ad altri. Ma proprio per questo il bilanciamento degli opposti interessi, e con esso la valutazione degli effetti della norma, dovrebbe stare alla base di ogni deliberazione normativa. Conoscere per deliberare, secondo il noto insegnamento di Luigi Einaudi.
La scarsa ponderazione del legislatore è spesso legata all’uso crescente dello strumento normativo del decreto legge, col quale il Governo ha facoltà di legiferare nei casi di “necessità e urgenza” salva la ratifica del Parlamento, con una procedura semplificata per la legge di conversione del decreto. Esula da queste brevi note l’indagine sui motivi (anche condivisibili) per cui questo strumento è sempre più utilizzato, a discapito dell’ordinario procedimento legislativo parlamentare (compreso quello della legge delega, che peraltro non sempre produce risultati qualitativamente migliori). Basti constatare che il breve tempo della formazione di un decreto legge evidentemente restringe le possibilità di ponderare le norme. Non solo: capita spesso che in sede di conversione sia colta l’occasione per inserire nel decreto ulteriori norme estranee al contesto di quel decreto.
Un esempio concreto è la norma che consente agli autotrasportatori di merce incaricati da altro trasportatore di agire per il pagamento del corrispettivo non solo verso quest’ultimo (col quale hanno il rapporto contrattuale), ma anche direttamente nei confronti del mittente principale e di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto. La norma è stata introdotta in sede di conversione di un decreto legge (art. 1-bis, comma 2, lettera e), d.l. n. 103 del 2010, convertito dalla legge n. 127 del 2010, che l’ha inserita quale art. 7-ter del precedente d.lgs. n. 286 del 2005 sull’autotrasporto), con l’evidente finalità di tutelare le piccole imprese di trasporto (spesso individuali, i c.d. “padroncini”) contro il rischio di non essere pagati.
Tale esigenza è indubbiamente sentita nel nostro Paese, notoriamente caratterizzato da un ampio tessuto di piccole imprese, non solo nell’autotrasporto ma in molti altri settori economici, e quindi da un’ampia diffusione di sub-contratti e sub-incarichi (si parla spesso del sub-appalto nell’edilizia), dove l’impresa prima incaricata a sua volta affida il lavoro ad altre e queste magari ad altre ancora, in una catena più o meno lunga di soggetti. L’ultima impresa, quella che esegue il lavoro, è spesso la più piccola e comunque è ovviamente la più esposta al rischio di mancato pagamento. Rischio, questo, che a sua volta è aggravato dalle altrettanto note debolezze del nostro sistema giudiziario, in particolare nel tutelare le obbligazioni contrattuali e il recupero dei crediti.
Dunque, l’intento di tutelare le piccole imprese di autotrasporto, che normalmente operano quali “sub-vettori” (su incarichi di altri trasportatori), per un rischio sui loro crediti, si è tradotto nella regola che dispone la responsabilità solidale del committente e degli eventuali altri soggetti della catena.
La posizione del committente non sembra essere stata neppure presa in considerazione: normalmente egli nulla sa dell’esistenza del sub-vettore e magari nell’incaricare il primo trasportatore ha pure pattuito il divieto di affidare il servizio ad altri (la stessa legge sull’autotrasporto prevede che il ricorso a subvettori debba essere autorizzato dal committente: art. 6 ter del d.lgs. n. 286/2005). E con questa norma potrebbe trovarsi a pagare il trasporto due volte, sia al vettore da lui incaricato sia al sub-vettore non pagato dal primo; il primo vettore è quindi insolvente e, non avendo pagato il sub-vettore, non rimborsa neppure il prezzo al committente.
In tal modo, il rischio di insolvenza o anche solo del recupero del credito, invece di essere affrontato “a monte” nell’efficientamento del sistema giudiziario, viene dalla norma traslato dal sub-vettore al committente, il quale potrebbe a sua volta essere una piccola impresa (come tale meritevole della stessa tutela) e comunque completamente estraneo all’assunzione di quel rischio (ignorando il sub-incarico), a differenza dal sub-vettore oggi tutelato.
Non a caso la norma ha generato un diffuso contenzioso, anche per la sua non impeccabile formulazione, con la reazione di molti committenti “colti di sorpresa” dalle pretese di sub-vettori a loro sconosciuti, per trasporti che avevano già pagato.
Fra l’altro, numerosi giudici hanno sollevato la questione di legittimità della norma davanti alla Corte Costituzionale, principalmente perché essa è stata introdotta dalla legge di conversione di un decreto legge, che però conteneva norme completamente diverse (verteva sull’esigenza, questa sì urgente, di disciplinare la liquidazione di Tirrenia Navigazione s.p.a. per garantire la continuità del trasporto marittimo); quindi veniva censurata la violazione del requisito di omogeneità funzionale tra decreto legge e legge di conversione (art. 77, comma 2, Costituzione).
La Corte ha però respinto la censura con due decisioni a breve distanza temporale, rispettivamente riferite a una serie di ricorsi dalla stessa Corte riuniti in due gruppi distinti: la prima (sentenza n. 226 del 2019) in poche righe di motivazione ha negato che vi sia una “manifesta mancanza” di un nesso fra il decreto legge e la norma introdotta con la sua conversione, solo perché entrambe riguardano situazioni di crisi in materia di trasporti, senza una parola per superare l’evidente diversità di queste situazioni; la seconda decisione si è limitata a rilevare l’esito della prima (ordinanza n. 93 del 2020).
In definitiva, neppure la Corte Costituzionale ha saputo fare chiarezza su una norma “nata male”, sia nei modi con cui è stata generata sia nella valutazione della sua portata.
Col tempo il sistema imprenditoriale saprà adattarsi a questa “smagliatura normativa”, così come ogni organismo in natura si adatta alle avversità. Rischi e incertezze (in questo caso in capo ai committenti) sono sempre metabolizzati e normalmente tradotti in maggiori costi scaricati sull’utenza. Alla fine, i crescenti difetti della produzione normativa equivalgono a maggiori costi per la collettività e ad una minore efficienza del “sistema Paese”.