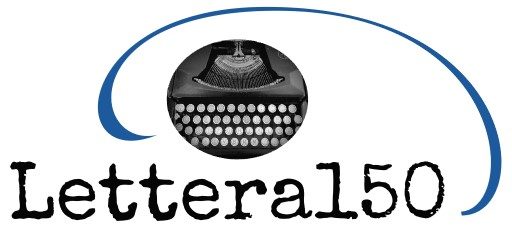Andrea Venanzoni, PhD in Diritto pubblico e costituzionale – Università di Roma Tre
‘Palantir è qui per infrangere i limiti tecnologici e rendere le istituzioni con cui collaboriamo il meglio che possa trovarsi in tutto l’occidente, quando è necessario atterrire i nemici e, a volte, ucciderli’. Sono parole di Alexander Karp, il CEO del colosso di analisi dei dati Palantir Technologies, pronunciate in occasione della colossale capitalizzazione della società, la quale nei primi giorni di febbraio 2025 ha superato la barriera dei 200 miliardi di dollari.
Una singola società americana il cui valore eccede i complessivi investimenti per l’innovazione tecnologica dell’Unione Europea.
Palantir non è solo una florida realtà del panorama tecno-industriale americano ma un solidissimo government contractor che lavora, anche, con i servizi di sicurezza, di intelligence e con la difesa americani, incarnando nella maniera più performante possibile la piena convergenza, autocosciente, tra innovazione tecnologica e hard power.
Rompendo, in certa misura, la tradizione ‘pacifista’ e quasi controculturale della vecchia Silicon Valley, giganti del Tech come Palantir o la Anduril Industries hanno raccolto il guanto metallico della difesa, in apparenza caduto in terra quando Google rinunciò al contratto con il Pentagono per i droni autonomi di Project Maven.
Questi nuovi giganti del Tech impersonificano la piena consapevolezza di come la pace possa essere raggiunta solo mediante la massima deterrenza, e in questa epoca di corsa all’accelerazione tecnologica la massima deterrenza si perfeziona lungo il crinale dell’innovazione.
Gli Stati Uniti di Donald Trump, attorno cui si stringono queste realtà, lo hanno capito bene.
La Cina lo ha capito parimenti bene, considerando come e quanto stia investendo e innovando da anni, sull’onda del monumentale progetto Made in China 2025, di cui DeepSeek, autentico ‘momento Sputnik’ cinese, è solo la perfezionata punta dell’iceberg.
Mentre l’Europa contempla ombelicalmente gli annunci regolatori, annegata in una spessa coltre di norme e regolamenti, su cui J.D. Vance, durante il summit parigino sull’intelligenza artificiale voluto da Emmanuel Macron, si è severamente soffermato.
E l’opinione pubblica italiana, surrealmente, a proposito di armi e conflitti, si attarda e accapiglia sulla effettiva attribuzione della frase ‘si vis pacem, para bellum’.
Dagli Stati Uniti ci arriva una lezione preziosa, quella della convergenza tra innovazione tecnologica e difesa, difesa della società, della libertà, dei valori occidentali, su cui Karp molto si sofferma nel suo libro ‘La Repubblica tecnologica’ che verrà nel corso del 2025 pubblicato anche in Italia.
Una lezione ben chiara a Mario Draghi; nel suo Rapporto sul futuro della competitività dell’Unione Europea la parola difesa ricorre oltre novanta volte, ma soprattutto essa viene accoppiata strutturalmente anche all’innovazione tecnologica.
Mentre si registra un passo indietro, significativo, nel più recente Libro Bianco sulla la difesa europea, che su un totale di ventitré pagine destina alla innovazione tecnologica solo una pagina e mezza, dai toni per vero piuttosto evanescenti e generici.
Quindi al di là dei nominalismi che tanto agitano gli inquieti sonni dell’opinione pubblica, ReArm Europe o meno, c’è un passo necessitato di autocoscienza da compiere; quello verso la piena consapevolezza che l’Italia, e l’Europa, per essere davvero sicuri, per avere garanzia di preservazione dei propri valori e della propria libertà, devono mettersi in cammino sulla strada della innovazione tecnologica.
Servono finanziamenti, reali e non meramente cartolari o raggiunti mediante illusioni ottiche contabili, per innovazione e ricerca, de-burocratizzazione feroce degli incombenti e degli oneri per ricercatori e imprese del settore privato più direttamente coinvolte in questo processo, superamento di atteggiamenti che al solo sentir parlare di difesa, sicurezza, armi, si rifugiano pavlovianamente nel rifiuto più completo.