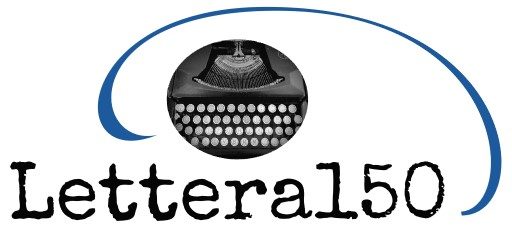Mario Eugenio Comba, professore ordinario di diritto pubblico comparato presso l’Università di Torino
Benedetto Croce, nella Storia d’Europa del secolo decimonono (1932), ricorda che la moderna religione della libertà è nata in Europa all’inizio dell’Ottocento, non solo dai moti delle nazioni oppresse contro i dominatori ma anche per soddisfare i bisogni di garanzie giuridiche, di partecipazione alle istituzioni di governo, di libera associazione e di aperta discussione delle idee, sviluppandosi in modo diverso nelle diverse nazioni europee ed in altre parti del mondo. Non ci si è giunti “per salto”, ma in seguito ad una lenta e progressiva elaborazione, che risale alla settecentesca Repubblica delle lettere ed ancor prima alle comuni radici cristiane, come ha illustrato Federico Chabod, nella Storia dell’idea di Europa (1961). In questo poderoso contesto storico e culturale va collocata la nascita delle istituzioni europee con i Trattati del 1957, poi l’evoluzione verso l’Unione europea con Maastricht del 1992 ed infine la definizione dell’attuale assetto con Lisbona nel 2007, che ha comportato anche l’incorporazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (volendo saltare le “tappe intermedie”). Credo sia necessario ricordare in estrema sintesi queste premesse per affrontare in prospettiva l’attuale crisi dell’Europa senza cadere nell’errore di confondere la cronaca con la storia.
Le critiche sono molte e non possono qui essere tutte riprese, ma in linea di massima paiono riconducibili a due principali argomenti, apparentemente contraddittori tra di loro: da una parte l’Unione europea avrebbe tradito il suo spirito originale perché sarebbe diventata un elemento limitativo della libertà anziché un propellente per la libertà; dall’altra essa avrebbe fallito la sua missione, ritrovandosi divisa ed inefficiente di fronte alle sfide tragiche dell’attualità: dall’immigrazione alla guerra in Ucraina alla recente imposizione dei dazi da parte degli Stati Uniti. Insomma, per certi aspetti, l’Europa sarebbe troppo forte e soffocante, mentre per altri sarebbe troppo debole e disunita; da una parte troppa Europa, dall’altra troppo poca.
E’ vero, l’apparato burocratico europeo è diventato un elefante che pretende di regolare in modo uniforme le questioni più minute su tutto il territorio dell’Unione, come testimoniano i molti casi riportati dalla cronaca (tra i più pittoreschi: le misure degli ortaggi, le gabbie delle galline, le caratteristiche tecniche dei WC …). Bisogna ammettere che spesso la responsabilità è degli Stati nazionali, che introducono regolazioni tecniche per il commercio di determinati beni diverse tra di loro e dunque tali da costituire vere e proprie barriere alla circolazione, rendendo così necessario l’intervento europeo per uniformare tali regolazioni e consentire la circolazione dei beni. Se le misure delle zucchine non fossero stabilite da ciascuno Stato membro in modo diverso, non sarebbe necessario l’intervento europeo per rendere uniformi tali misure. Però una soluzione tecnica a tale problema, davvero ispirata al principio della libertà, esiste già e sta nel principio di mutuo riconoscimento: se un prodotto può essere legittimamente venduto in uno Stato membro, allora può circolare in tutta Europa, anche se con misure e caratteristiche diverse. Si tratta di scegliere la soluzione più semplice (mutuo riconoscimento) rispetto a quella che aumenta il livello di regolazione (uniformazione europea dei requisiti tecnici). Saranno poi i consumatori europei a far prevalere il prodotto migliore con le loro scelte: lo zucchino più o meno lungo, il WC con una forma o un’altra.
In altri casi, più complessi, l’eccesso di regolazione europea deriva da scelte politiche di fondo, come quando il dogma della concorrenza travolge alcune elementari regole di buon senso (per esempio in materia di contratti pubblici), oppure quando viene imposta un’ideologia verde (Green Deal) senza tenere conto delle realtà industriali nazionali e neppure del livello raggiunto da altre tecnologie, oppure ancora quando si pretende di regolare in modo minuzioso e definitivo il fenomeno dell’IA.
A ben vedere, quando ci si lamenta per la troppa Europa, si mette in discussione la tendenza ad annullare le differenze nazionali nel nome di una mal intesa esigenza di uniformazione complessiva, anche là dove tale uniformazione non è necessaria ed il disegno dei Trattati vuole invece preservare le differenze. E qui occorre una precisazione: non bisogna temere né demonizzare il concetto di identità nazionale perché è lo stesso Trattato sull’Unione Europea (TUE) a riconoscerne il ruolo fondamentale all’articolo 4: “L’Unione rispetta l’uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali (…)”. Le identità nazionali degli Stati membri sono dunque un polo fondamentale della dialettica istituzionale europea, insieme ai valori comuni riconosciuti dall’art. 2 TUE “L’Unione si fonda sui valori della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti alle minoranze (…)”. Il difficile equilibrio che deve essere continuamente ricercato dalle istituzioni europee e nazionali è dunque quello tra valori comuni e identità nazionali, dove però non si deve vedere una contrapposizione ma una integrazione, nell’ambito di quello che Von Bogdandy, in The Idea of European Public Law Today (2017) ha definito lo spazio giuridico europeo. Le identità nazionali sono gli elementi sulla base dei quali vengono costruite le tradizioni costituzionali comuni (art. 6 TUE), nell’ambito dei valori comuni, così come i diritti nazionali sono un elemento costitutivo dello – e non oppositivo allo – spazio giuridico europeo.
Il richiamo alla dialettica tra identità nazionali e valori comuni, nell’ambito dello spazio giuridico europeo, consente di affrontare in modo sistematico il tema della troppo poca Europa. Là dove sia necessario difendere i valori comuni è consentita – ed anzi, è richiesta – una qualche compressione delle identità nazionali, che devono comunque essere preservate nella loro essenzialità. D’altra parte, l’adesione ai valori comuni è dato come presupposto dall’articolo 2 TUE e dunque il perseguimento dei valori comuni non comporta compressione, ma piuttosto esaltazione delle identità nazionali. In termini concreti, questo comporta la necessità di introdurre riforme procedurali (votazione a maggioranza) ed istituzionali (maggiore rappresentatività degli organi, ivi compresa l’ipotesi di elezione diretta del Presidente della Commissione) per consentire iniziative europee più intense ed efficaci là dove – e solo là dove – esse siano effettivamente necessarie.
Insomma, occorre concentrare le risorse e la credibilità politica europee sulle azioni necessarie a preservare innanzitutto la pace, il benessere ed i valori dei popoli europei (art. 3.1 TUE), nonché la libertà e la sicurezza dei cittadini (art. 3.2 TUE) introducendo le necessarie riforme affinché la religione della libertà di cui parlava Benedetto Croce, nelle mutate forme in cui essa si è inevitabilmente evoluta, continui a rappresentare la vera essenza del modello europeo.