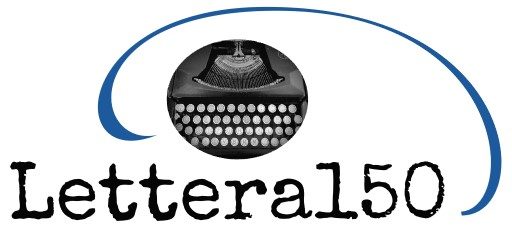Antonio Fuccillo, Professore ordinario di Diritto e religioni e Diritto interculturale, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Giurisprudenza
1.- I recenti fatti di cronaca hanno riacceso i riflettori sul ruolo e le funzioni della Corte penale internazionale.
Istituita nel 1998 dal Trattato di Roma, essa ha iniziato le proprie attività quattro anni più tardi, al raggiungimento del quorum fissato dall’art. 126 dello Statuto. I paesi che attualmente hanno aderito sono 125, tra cui non rientrano Stati Uniti, Israele (sì, invece, la Palestina), Russia e Cina.
La CPI esercita il suo potere giurisdizionale sulle persone fisiche per i più gravi crimini di portata internazionale e ha una giurisdizione complementare a quella degli Stati (art. 1 Statuto).
A norma dell’art. 4 dello Statuto, la CPI possiede personalità giuridica internazionale e ha la capacità giuridica necessaria per il conseguimento dei suoi obiettivi. Può esercitare le proprie funzioni nel territorio di qualsiasi Stato Parte qualora quest’ultimo non sia in grado o non abbia la volontà di applicare le proprie leggi per sanzionare determinati reati, nel rispetto del diritto internazionale. Mediante specifici accordi, essa inoltre può intervenire anche nel territorio di altri Stati.
La competenza della Corte è limitata ai crimini più gravi, motivo di allarme per l’intera comunità internazionale e, in particolare, al crimine di genocidio, ai delitti contro l’umanità, ai delitti di guerra e al crimine di aggressione (art. 5).
Si tratta, come è ovvio, di un organismo sovranazionale deputato alla tutela effettiva dei “diritti umani” così come declinati sia dalle Carte internazionali (CEDU) che dalla giurisprudenza delle Alte Corti.
La Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale su uno dei crimini su richiamati quando uno Stato Parte o il Consiglio di Sicurezza ONU segnalano al Procuratore una situazione nella quale uno o più di tali crimini appaiono essere stati commessi. In tale modo si richiede a detto ufficio di effettuare indagini sulla situazione segnalata, al fine di stabilire se una o più persone determinate debbano essere accusate di tali crimini (artt. 13-14). Il Procuratore può comunque iniziare le indagini di propria iniziativa sulla base di informazioni relative ai crimini di competenza della Corte.
Il Prosecutor deve valutare la serietà delle informazioni ricevute e può richiedere ulteriori informazioni agli Stati, agli organi delle Nazioni Unite, alle organizzazioni intergovernative e non governative o alle altre fonti ritenute affidabili. Se il Procuratore conclude che v’è un ragionevole fondamento per avviare indagini, presenta alla Camera Preliminare una richiesta di autorizzazione alle indagini.
Attualmente il procuratore capo è Karim Asad Ahmad Khan, eletto nel giugno 2021 (UK).
2.- La Corte applica il proprio Statuto e, ove necessario, basa la propria azione sui trattati e le regole di diritto internazionale, ivi compresi i valori consolidati del diritto internazionale dei conflitti armati. In assenza di ciò, essa è tenuta ad applicare i principi generali di diritto ricavati dalla Corte in base alla normativa interna dei sistemi giuridici del mondo, compresa, ove occorra, la normativa interna degli Stati che avrebbero avuto giurisdizione sul crimine. Il tutto purché tali principi non siano in contrasto con lo Statuto, il diritto internazionale e con le norme ed i criteri generalmente riconosciuti (art. 21).
I profili di intervento tuttavia dovrebbero seguire due principali scopi:
- Intervenire quando gli ordinamenti nazionali hanno fallito;
- Agire in presenza di chiare evidenze che sfuggono alle attività di indirizzo politico degli Stati.
È infatti facile comprendere che non rientra tra i compiti della Corte il giudizio politico sui governi degli Stati. Rientrano infatti tra le attività caratterizzanti l’azione politica quelle legate ai delicati rapporti interazionali, alle relazioni tra stati sovrani, alla difesa dei propri territori.
La Corte penale internazionale non è (e non può essere) quindi il Giudice supremo di tali attività, né un “giudice universale” cui è demandato un verdetto morale sull’azione degli stati. Se ogni azione politica dovesse infatti superare tale controllo di “eticità universale” demandato alla azione della CPI, si creerebbe il paradosso di impedire la libera autodeterminazione degli stati coinvolti.
I casi Netaniau e Almasri hanno infatti messo in chiara evidenza proprio una sovraesposizione in tale senso della CPI. Tali giudici, infatti, intervengono direttamente nel processo di autoprotezione dei singoli stati nazione, con provvedimenti ad alto impatto mediatico, al fine di attribuire a singoli atti “politici” una sorta di disapprovazione universale. In tale modo quindi, la CPI si arroga un potere di giudizio non più tecnico-giuridico. Essa esce quindi decisamente dal suo campo di azione, per assumerne uno più prettamente politico.
La Corte penale internazionale, tuttavia si deve occupare dei crimini internazionali commessi dagli individui e non deve interessarsi degli Stati. La qualificazione giuridica delle fattispecie da sottoporre al suo giudizio deriva però anche dal diritto internazionale consuetudinario, il che sembra lasciare una certa arbitrarietà nella individuazione delle condotte da reprimere, ancorché elencati in modo tassativo nello Statuto. Si tratta di un vulnus importate nella azione della Corte, che lascia troppi spazi aperti ad una gestione dei casi politica invece che prettamente giuridica.
Sul sito web della CPI (https://www.icc-cpi.int) si legge chiaramente quale è l’ambito di esercizio della azione penale da parte dell’Ufficio del Procuratore (OTP) che è un organo indipendente della Corte. Esso è “responsabile dell’esame delle situazioni sotto la giurisdizione della Corte in cui sembrano essere stati commessi genocidi, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e aggressioni, e di svolgere indagini e procedimenti penali contro le persone presumibilmente maggiormente responsabili di tali crimini”. L’attività della Corte sembra quindi limitata a fatti estremamente gravi, così come condannati dalla generalità dei popoli, e slegati da singole azioni e soprattutto avulse da un giudizio esclusivamente politico.
È la prima volta nella storia, infatti, che un numero sempre crescente di Stati si affida a un procuratore internazionale. Egli deve perciò svolgere “il mandato di selezionare in modo indipendente e imparziale le situazioni da indagare in cui crimini atroci sono stati o continuano a essere commessi sui loro territori o da loro cittadini” (https://www.icc-cpi.int). Alcuni episodi recenti, tuttavia, sembrano proprio minare alla “indipendenza” e “imparzialità” della azione della Corte, con il paradossale risvolto negativo di minarne il prestigio.
Se, infatti, l’attività della CPI esce dalle proprie regole di ingaggio finirà per non potere più esercitare una efficace azione nelle fattispecie che le sono proprie, e rischia di provocare l’effetto boomerang di una uscita degli stati dal trattato di Roma e di una cospicua riduzione dei finanziamenti necessari all’attività della Corte (caso USA, ad esempio).
È necessario forse anche rivedere i criteri di selezione dei giudici della Corte, al fine di evitare la partecipazione a un così delicato organo di soggetti fortemente ideologizzati o provenienti da paesi con tale caratterizzazione. Essa ad oggi è presieduta da Tomoko Akane (Giappone),sono poi presenti giudici di altre 18 stati tra cui l’Italia (Canada, Messico, Georgia, Sierra Leone, Perù, Costa Rica, Uganda, Benin, UK, Slovenia, Francia, Tunisia, Rep. Korea, Trinidad e Tobago, Mongolia, Romania), nazioni tuttavia non sempre di grande e consolidata tradizione giuridica.
La CPI, insomma, deve essere e apparire imparziale, avulsa da giudizi politici, e agire nei propri stretti ambiti di competenza, assicurando alla giustizia criminali che, per qualche ragione, sfuggono alla presa dei singoli stati ove sono state commesse le azioni delittuose.
D’altra parte, vale la pena ricordare, quali sono le caratteristiche del Giudice, che valgono ovviamente anche per la CPI, “È infatti proprio di un giudice saggio considerare che dal popolo gli è consentito quel tanto che gli è stato consegnato e affidato, e ricordarsi che non solo gli sono stati dati dei poteri, ma che si è anche riposta fiducia in lui; avere la possibilità̀ di assolvere chi odia, condannare chi non odia, e pensare sempre non a ciò che egli personalmente vuole, ma a ciò che la legge e lo scrupolo impongono; tenere bene a mente in base a quale legge l’accusato sia chiamato in giudizio, su quale accusato egli istruisca la causa, su quale tema verta il dibattito” (Cicerone)[1].
Moniti, che ancora oggi sono necessari perché chi assume un potere di giudizio sulle azioni altrui, lo eserciti con perizia e prudenza, e nel caso della Corte penale internazionale quindi, lo esplichi con attenzione a non sfociare in giudizi politici sui governi coinvolti che avrebbero l’unico effetto di minare alla stessa azione della Corte.
[1] «Est enim sapientis iudicis cogitare tantum sibi a populo Romano esse permissum quantum commissum sit et creditum, et non solum sibi potestatem datam verum etiam fidem habitam esse meminisse; pos- se quem oderit absolvere, quem non oderit condemnare, et semper non quid ipse velit sed quid lex et religio cogat cogitare; ani- madvertere qua lege reus citetur, de quo reo cognoscat, quae res in quaestione ver- setur» (Cicerone – Orationes – Pro Cluentio – 58).