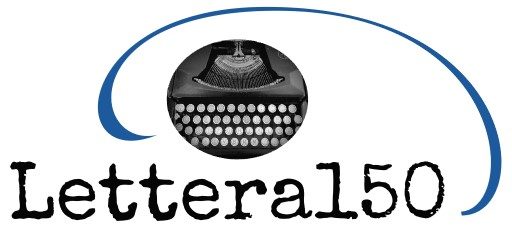Mario Rusconi, preside del liceo Pio X di Roma e Mario Alì, già direttore generale del MIUR
Premessa metodologica
Il punto di partenza di un manifesto per una nuova società della conoscenza non può che fondarsi sulla ricostruzione del paradigma valoriale, attraverso una riflessione istituzionale, culturale e strutturale sui sistemi educativi, di alta formazione e di ricerca. Un edificio non si crea dal tetto ma dalle sue fondamenta e tali fondamenta dovrebbero essere costituite dai legami intergenerazionali, da una condivisione della trama sociale e del patrimonio della conoscenza. Antonio Ruberti affermava che:
“…c’è il rischio di polarizzare l’attenzione sul trasferimento dei saperi, sulla loro diffusione e sulla loro utilizzazione…e di lasciare in secondo piano la produzione dei saperi e dunque la ricerca. Una tale asimmetria…è in contrasto con la caratteristica centrale della società della conoscenza, che sta proprio nella crescita dei saperi e del loro ruolo…Quando parlo di saperi mi riferisco a tutto l’insieme delle conoscenze: al sapere organizzato, scientifico tecnologico ed umanistico-artistico, prodotto degli intellettuali di professione; al sapere organizzativo, prodotto dalle organizzazioni (imprese e istituzioni); al sapere popolare di singoli e di gruppi (dai diari alle collezioni, dal dilettantismo al folclore.”
Le restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19 hanno evidenziato la funzione positiva dell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione, mettendo in luce altresì alcuni dei suoi effetti perversi, stressando non solo le attività funzionali e strutturali, ma anche l’aspetto più emotivo, a causa della disincarnazione delle relazioni interpersonali.
Complessità sociale
I fattori di criticità sociale, culturale e ambientale collegati alla premessa sono essenzialmente che:
▪ nel prossimo futuro la questione demografica assumerà una rilevanza ineludibile. Se da un lato la natalità in Italia è in diminuzione del 30% con un paritario incremento del 28% degli anziani nei prossimi dieci anni, d’altro canto la popolazione globale è in crescita esponenziale, specialmente nelle città e si avvia rapidamente agli 8 miliardi di persone;
▪ la crisi migratoria globale, il cui numero è stimato dalle Nazioni Unite nel 3% della popolazione globale è funzione sia della crescita demografica esponenziale, sia delle condizioni di vita che portano alla migrazione per effetto del clima, dei conflitti e del generale bisogno di migliorare la propria condizione economica;
▪ la recente crisi ambientale globale è un ulteriore fattore di instabilità sociale dal momento che la biodiversità, ovvero la varietà di specie floreali e faunistiche presenti sulla Terra, verità necessaria a sostenere la vita sul pianeta, è in allarmante diminuzione, andando ad incidere sia sull’ambiente, sia sui sistemi economici, e soprattutto sulla qualità della vita delle persone;
▪ al fattore ambientale si associano oggi gli effetti dell’attuale pandemia da Covid -19, che è solo l’ultima di una serie di epidemie più o meno gravi che l’aumento della popolazione globale e la concentrazione di essa nei sistemi urbani renderanno nel futuro un rischio sempre più frequente;
▪ bisogna prendere atto del fatto che il sistema scolastico e quello universitario non sembrano più in grado di garantire un efficace processo di mobilità sociale verticale – il cosiddetto ascensore sociale – ed il collegato graduale, progressivo miglioramento della qualità di vita e di lavoro;
▪ dalla diminuita efficacia sociale dei processi educativi deriva la scarsa diffusione della necessaria coscienza critico/interpretativa della realtà, con conseguente sfiducia nella scienza e nella ricerca. Medesima sfiducia che si indirizza nei confronti delle istituzioni, nazionali ed europee, così come i risultati elettorali degli ultimi anni dimostrano chiaramente.
Alcune proposte
A fronte del quadro di oggettiva criticità che si evince dalla lettura della situazione italiana nel contesto europeo e globale, si evidenziano alcune proposte:
▪ porre al centro di qualunque processo sociale ed economico del Paese l’educazione e la formazione ad ogni livello, non solo quale mandato del Ministero dell’università e della ricerca o del Ministero dell’istruzione e del merito, ma anche come azione trasversale a tutte le politiche settoriali di Governo;
▪ restituire credibilità ai processi formativi ed ai loro attori attraverso investimenti sostanziali, che non siano limitati ad interventi emergenziali. A tale proposito sarebbe auspicabile, così come si sta finalmente procedendo alla realizzazione di un PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), prevedere la realizzazione di un piano pluriennale nazionale di ripresa e rilancio delle Scuole, delle Università, delle Accademie e Conservatori e degli Istituti di ricerca. Un piano pluriennale aggiornabile annualmente e dedicato al rilancio di tutte le nostre istituzioni culturali e di ricerca; una piccola finanziaria della cultura e della ricerca, dedicata esclusivamente al rilancio di tutte le nostre istituzioni culturali, Istituzioni che tutto il mondo ci invidiano. Si darebbe, in questo modo, una risposta concreta ai richiami contenuti negli artt. 9 e 33 della nostra Costituzione.
▪ collocare al centro del dibattito politico e sociale l’etica della responsabilità, ovvero del ruolo di ciascuno rispetto alla società;
▪ attribuire la massima attenzione alla difesa e diffusione della lingua italiana, la cui marginalizzazione pone a rischio la nostra stessa identità, come strumento di valorizzazione internazionale del nostro patrimonio culturale e scientifico, anche a fronte delle sfide demografiche e di quelle migratorie;
▪ il capitale immateriale deve diventare la prima industria del Paese, con particolare attenzione alla filiera dei saperi umanistici che alimentano la società della conoscenza;
▪ operare per una minor frammentazione e polverizzazione dei fondi destinati alla ricerca tra diverse istituzioni e dicasteri evitando duplicazioni e sprechi, creando così le condizioni per partecipare a grandi progetti nazionali europei. Ciò permetterebbe un più efficace coordinamento e una valorizzazione dei risultati della ricerca con adeguate ricadute dei progetti sul prodotto interno lordo e sul riconoscimento dell’utilità sociale della scienza;
▪ dedicare maggiore attenzione ai temi della transizione ecologica, della lotta ai cambiamenti climatici ed alla perdita di biodiversità per la piena consapevolezza della loro necessità e la relativa elaborazione di obbiettivi giuridicamente vincolanti per la tutela;
▪ intervenire contro ogni forma di discriminazione, riconoscendo anche nel nostro Paese la piena parità di genere, valorizzando le diversità in una prospettiva di inclusione e di eguaglianza;
▪ impegnarsi affinché anche la comunicazione diventi strumento fondamentale per veicolare informazioni affidabili, supportate tecnicamente e scientificamente e tali da contribuire alla formazione di una corretta percezione della realtà nei cittadini.
▪ In questo scenario, la sfida sociale, economica e culturale è evidente: dobbiamo evitare a tutti i costi che la generazione presente, soprattutto alla luce degli effetti della pandemia e delle guerre in atto, divenga una “generazione perduta”, la cui povertà educativa impedisca loro di diventare attori adeguati nella società di domani. Ciò significa trovare un lavoro dignitoso, che valorizzi i talenti personali e le competenze acquisite, allo scopo di poter realizzare il proprio progetto di vita.
Nella lettera enciclica: “Fratelli tutti”, dedicata dal Santo Padre Francesco alla fraternità e all’amicizia sociale, egli afferma con decisione che: “…Ogni essere umano ha diritto a vivere con dignità e a svilupparsi integralmente, e nessun Paese può negare tale diritto fondamentale”, dando quindi centralità sociale al tema dello sviluppo integrale della persona che solo l’educazione consente e la cui assenza implica l’esclusione dai processi decisionali e culturali della società. In linea con l’affermazione del Papa, il “capitale immateriale” delle persone, anche le più svantaggiate, è un bene specifico, unico, straordinario e lo Stato deve far sì che ciascuno sia messo effettivamente nelle condizioni di dare questo bene alla società.
Il modo migliore per interpretare il senso di queste proposte è nel titolo dei libri, pubblicati insieme a molti amici. Questo è l’auspicio da cui partire, per immaginare un nuovo rinascimento dell’Italia e dell’Europa nel contesto internazionale, e ridare un senso ad ogni singolo individuo nel contesto sociale di riferimento, rendendolo da potenziale soggetto emarginato in protagonista consapevole di tale Rinascimento. Ed è proprio da questo concetto che nasce la grande idea di riprendere il cammino interrotto di uno “Spazio europeo della formazione, dell’Università e della ricerca”, uno spazio europeo aperto che opera ad integrazione e a sostegno dello spazio economico e politico, uno spazio di dialogo e di confronto, che è mancato in questi anni, ma la cui apertura diviene necessaria e oggi urgente per la rinascita della costruzione europea. Il nostro Paese ha tutte le carte in regola per candidarsi a guidare la creazione di questo importante progetto europeo. L’Europa delle conoscenze, del capitale immateriale, delle idee dovrà costruirsi non in opposizione alla crescita quantitativa ed economica, ma servirà come componente essenziale per incrementare la sua crescita.