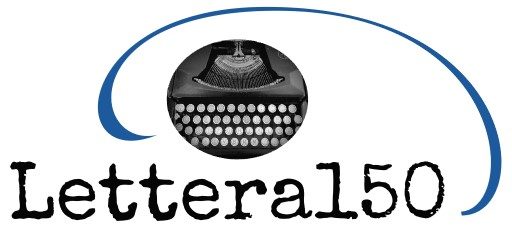Vincenzo Mannino, professore emerito all’Università Roma Tre
Per alcuni giorni ha preso la scena nei media e nei giornali il Manifesto di Ventotene, il documento da molti considerato un momento fondativo del progetto dell’Unione europea, scritto nel 1941 da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e con l’apporto di Eugenio Colorni durante il loro confino nell’isola di Ventotene. A mente fresca è forse giunto il momento di procedere a qualche riflessione di ordine generale.
Il Manifesto, visto nella prospettiva storica, rimane una fotografia nitida dell’aspirazione a un’Europa libera e unita negli ‘anni bui’ della seconda guerra mondiale. Non a caso il titolo originale del documento era Per un’Europa libera e unita. Progetto d’un manifesto.
Le ragioni dell’interesse manifestato da media e giornali ha riguardato il fatto che Giorgia Meloni ha interrogato la sinistra sul messaggio da essa dato qualche giorno prima del suo intervento distribuendo quel testo in varie manifestazioni di piazza organizzate dal milieu di sinistra. Il Presidente del Consiglio, in particolare, aveva manifestato il suo dissenso in merito ad alcuni passaggi del Manifesto, come quello che la ‘rivoluzione europea, per rispondere alle nostre esigenze, dovrà essere socialista’, la ‘proprietà privata deve essere abolita, limitata, corretta, estesa caso per caso’, ‘nelle epoche rivoluzionarie, in cui le istituzioni non debbono già essere amministrate, ma create, la prassi democratica fallisce clamorosamente’. Insomma, Il Presidente Meloni aveva più specificamente voluto richiamare l’attenzione su una visione in cui traspare l’idea di una società ispirata ai valori del socialismo e della rivoluzione, ma anche di un popolo non in grado di autodeterminarsi, di un popolo da educare piuttosto che ascoltare, di un superamento dello Stato nazionale considerato ormai obsoleto e causa di guerre e stragi.
Il quesito posto da Giorgia Meloni ha immediatamente suscitato a sinistra ‘alti lai’, con accentuazioni esagerate (addirittura un parlamentare ha concluso il suo intervento fra le lacrime). Tutto legittimo. Tuttavia, non si può nascondere la sensazione di una indignazione permeata da pregiudizio e da unilateralismo, finendosi per negare alquanto grottescamente che un testo datato non possa essere sottoposto a valutazione critica a distanza di ottant’anni dal suo concepimento. Come se avesse un che di sacrale e di intangibile. Siamo di fronte a visione della storia caratterizzata da immobilismo concettuale e interpretativo. Una visione viziata da una postura ‘conservativa’. Alquanto in contrasto con l’immagine di sé che dovrebbe dare chi si vuole (auto-)definire a ogni piè sospinto progressista.
Il Manifesto fu un documento scritto da persone che nel loro stato di oggettiva costrizione fisica e di pensiero intendevano ‘gridare’ al mondo il loro convincimento in merito all’esigenza da loro avvertita di avere una federazione europea senza Stato/i quale unico viatico per la realizzazione di un mondo di pace e di liberazione dell’uomo nel segno di una società socialista. Si trattava di un evidente salto logico. Si trasformava un desiderio in realtà, per superare la tragedia della guerra in atto con i suoi riflessi negativi a livello individuale e collettivo.
Il Manifesto venne strutturato da Colorni in tre capitoli (La crisi della civiltà moderna, Compiti del dopoguerra. L’unità europea, Compiti del dopoguerra. La riforma della società) e, se voleva comprensibilmente avere un respiro ampio, nel suo esito rappresentativo pagava pegno proprio alla particolare situazione in cui si trovavano immersi i suoi autori: uomini cui veniva negata la libertà. Forse, anche per questo dato oggettivo, il Manifesto esprime una lettura in un certo senso ‘zoppa’ nella sua considerazione piena della realtà e ‘sbilanciata’ per un salto nell’utopia.
Si omette così qualsivoglia valutazione di quanto accadeva nell’Unione sovietica stalinista, dove si andava sviluppando un sempre più marcato autoritarismo totalitario e illibertario. L’unico giudizio negativo rispetto a questo possibile esito, al di là dell’esperienza sovietica, finisce per essere rivolto al totalitarismo di stampo nazifascista, presentato, a sua volta, come una sorta di ‘blocco storico’ nello sviluppo della civiltà moderna. A siffatto blocco avrebbe dovuto meccanicisticamente seguire la nascita di un’Europa unita e libera, improntata all’emancipazione delle classi lavoratrici, al superamento di ogni diseguaglianza e privilegio sociale, con l’avverarsi della rivoluzione socialista, il cui prototipo ideale del momento – pur con tutti i ‘distinguo’ possibili – non poteva non rimanere agli occhi degli estensori del Manifesto la rivoluzione sovietica del 1917, obliterandone ogni torsione in senso illibertario. Entro questo quadro si spiegano i richiami a una vita economica europea liberata dagli incubi del militarismo o del burocratismo nazionale, ma anche all’abolizione, limitazione, correzione della proprietà privata.
Si trattava, però, di una visione tranchant. Restava fuori qualunque altro ipotetico sbocco teorico e fattuale.
Sotto il primo punto di vista, per esempio, gli estensori del Manifesto obliterarono il diverso pensiero espresso dopo la prima guerra mondiale dall’austriaco Kalergi nel libro Paneuropa, dove si prefigurava un’Europa che sapesse unitariamente opporsi a un nuovo conflitto mondiale. Il messaggio di Kalergi, senza volergli assegnare nessun privilegio rispetto ad altri, susciterà attenzione da parte di varie personalità tutt’altro che marginali nella storia culturale e politica europea. A cominciare da Adenauer, Robert Schuman, Alcide De Gasperi, Wiston Churchil. Il ‘percorso’ verso un’Europa unita in una Confederazione estesa dal Portogallo alla Polonia e dalla Scandinavia alla Romania era per Kalergi diverso da quello che avrebbe ispirato il Manifesto di Ventotene. Si basava sull’idea di un nazionalismo che si facesse europeismo. In altri termini, il rafforzamento degli Stati nazionali sovrani sarebbe sfociato, ancorché lungo percorsi non sempre chiari, nell’unità europea. Comunque, senza alcuna rivoluzione socialista.
Sotto il punto di vista fattuale, invece, è evidente lo scarto fra la visione di Europa unita espressa nel Manifesto di Ventotene e quanto di lì a poco sarebbe accaduto nell’Europa occidentale, orientatasi verso un assetto politico in contrapposizione al blocco sovietico e alla sua ispirazione socialista.
Insomma, la storia delle idee e della politica, anche quella intorno al Manifesto di Ventotene, è piena di nuance. Non si vede, perciò, quale sia lo scandalo della richiesta di approfondimento in merito ad alcuni suoi passaggi (non certo marginali) a chi lo assume senza se e senza ma come propria bandiera di riferimento e come base insuperabile della costruzione di un’Europa unita nel segno del superamento della statualità nazionale. Rifiutarsi di rispondere sdegnosamente alla domanda è segno di una postura illiberale, cui fa semplicisticamente pendant l’accusa a chi la pensa diversamente da sé di essere fautore di pericoloso anti-europeismo, se non di retrivo e pericoloso nazionalismo.