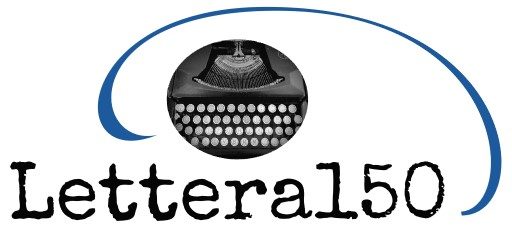Alessandro Amadori, politologo e sondaggista
Da quando si è insediato alla Casa Bianca, Donald Trump è diventato il protagonista assoluto della geopolitica e dell’economia mondiali. Le sue decisioni rapide, drastiche e imprevedibili hanno spiazzato tanto i governi quanto le opinioni pubbliche. Per cui una domanda sorge veramente spontanea: che cosa ne pensano gli italiani? Secondo una rilevazione dell’istituto di ricerca YouTrend per Sky TG24, l’80% degli italiani ha valutato negativamente l’introduzione delle nuove tariffe commerciali, sin dal primo annuncio fatto dal presidente degli Stati Uniti. Più in generale, oggi l’opinione pubblica nazionale sul presidente americano Donald Trump appare, dalle risultanze di un sondaggio realizzato da Ipsos e divulgato alcuni giorni fa, prevalentemente negativa. Infatti, una netta maggioranza, pari al 73%, ha espresso disapprovazione nei confronti del leader statunitense, mentre solo il 17% (un italiano su sei) si è dichiarato favorevole. Il restante 10% non ha espresso un’opinione.
Il fatto è che la politica commerciale di Trump, e in particolare la sua scelta di introdurre un sistema universale di dazi commerciali, hanno sollevato notevoli preoccupazioni tra i nostri concittadini. Sempre secondo Ipsos, il 61% degli intervistati si è detto preoccupato per le possibili ripercussioni di queste misure, mentre il 24% non ha espresso timori in merito. Il restante 15% non ha preso posizione su questo tema.
Al di là dei dati demoscopici, di per sé molto chiari, vi sono poi le conseguenze pratiche delle decisioni americane sui mercati finanziari. Da quando Trump ha annunciato i nuovi dazi il 2 aprile 2025, le borse mondiali, compresa quella italiana, hanno assunto un andamento fortemente altalenante, con cali bruschi seguiti da improvvisi rimbalzi. Nessuno sa dire esattamente che cosa succederà nelle prossime settimane, ma una cosa è certa: sui mercati regnano incertezza e instabilità. La metafora più utilizzata, dagli stessi esperti di mercati finanziari, è quella dell’ottovolante.
Che cosa può spiegare un comportamento presidenziale così imprevedibile e, soprattutto, apparentemente insensibile alle conseguenze potenziali di decisioni improvvise e fortemente di rottura? Donald Trump è una figura complessa e polarizzante, ancora non ben compresa sul piano politologico. Il suo è infatti un profilo ambivalente, che può suscitare forti entusiasmi e adesioni (anche e soprattutto sul piano emozionale) e, parallelamente, altrettanto forti resistenze e rifiuti.
Come personaggio politico, in termini positivi, Trump è un leader molto ambizioso e altamente competitivo che, quando entra in gioco, lo fa per spiazzare gli avversari, vincere (appunto con mosse a sorpresa) e tenere ben saldo il comando (tutti fattori che lo rendono molto orientato ai risultati, specialmente di breve periodo). Inoltre, ama essere al centro dell’attenzione, e sa usare molto bene i mezzi di comunicazione per richiamare costantemente l’attenzione dell’opinione pubblica su di sé, attraverso un vero e proprio show personale (cosa che lo rende non solo molto visibile, ma anche fortemente carismatico, sul suo elettorato di riferimento). In aggiunta, egli pratica quello che tecnicamente si chiama “pensiero divergente”: ha molte idee e una grande immaginazione, il che lo porta a cercare soluzioni innovative (e talvolta davvero non convenzionali) ai problemi.
In termini meno positivi, la sua caratteristica più distintiva è un’audacia che tende a sfociare nel vero e proprio azzardo (sino a far pensare che sia un “sensation seeker”, ossia una persona con una elevata tolleranza al rischio e una curiosità quasi insaziabile per l’ignoto). Inoltre, Trump è estremamente sicuro di sé, con un certo sentimento di grandiosità che lo porta a considerarsi in grado di intraprendere qualsiasi tipo di azione. Questo ne fa un personaggio davvero originalissimo nell’attuale panorama delle leadership mondiali. In aggiunta, è molto diretto sia nelle azioni che nelle comunicazioni, e altamente resistente alle critiche provenienti dall’establishment. Infine, il presidente americano è piuttosto insofferente alle regole formali e tende a prendere decisioni estremamente veloci, riservando a un secondo momento una più attenta considerazione dei dettagli e delle sfumature della situazione. Per poi, pragmaticamente, riadattare la sua linea di azione a mano a mano che le circostanze evolvono. Il che spiazza ulteriormente gli interlocutori politici internazionali, non abituati a gestire un’interazione contraddistinta dalla strategia della “rimodulazione situazionale”.
Questi tratti aiutano a comprendere meglio molti dei suoi comportamenti e il modo in cui ha impostato sin dall’inizio il nuovo mandato presidenziale. Nel suo caso, ancora più che a proposito di altri leader, è dunque fondamentale tenere in considerazione il fattore umano. Un personaggio così originale non poteva che adottare uno stile di azione e di comunicazione caratterizzato dal “pensiero laterale”: abbandonare la via tradizionale, rompere gli schemi, cambiare radicalmente prospettiva nell’esame di un problema. E provare a riformulare le regole del gioco. Per ottenere che cosa? Una vera e propria ridefinizione degli equilibri mondiali, partendo dall’idea che il modello di globalizzazione, che ha imperato negli ultimi venti anni, non sia più sostenibile.
Tutto questo, cosa comporta per la politica italiana? Come abbiamo visto dai dati demoscopici, alla figura di Donald Trump è bene relazionarsi con equilibrio e una certa prudenza. Nella consapevolezza della sua dissonanza rispetto alle liturgie della politica europea, ma anche del potenziale trasformativo della sua presidenza. Per capire questo aspetto, un saggio molto interessante è il libro di Glauco Maggi, intitolato “Trump. La rivincita” (Edizioni Mind, Milano, 2024). Maggi descrive molto bene come Trump abbia saputo sfruttare il malcontento della classe media americana, impoverita dall’inflazione e, nonostante le accuse di razzismo che gli sono state indirizzate, abbia aumentato fortemente il suo consenso proprio tra gli elettori neri e ispanici.
Il libro esplora anche il fenomeno del “populismo proletario” che caratterizza la cosiddetta “America Flyover Country”, disprezzata dalle élite delle coste. Il nome deriva dall’idea che queste aree siano semplicemente “sorvolate” durante i voli tra le città costiere, senza ricevere molta attenzione. Si tratta di regioni caratterizzate da una forte presenza di comunità rurali e di piccole città, con un’economia basata principalmente su agricoltura, industria manifatturiera e altre attività tradizionali. Gli abitanti della Flyover Country si sono sentiti a lungo ignorati o sottovalutati dalle politiche nazionali e dai media, che tendono a concentrarsi sulle grandi metropoli costiere. E hanno trovato in Donald Trump un vero e proprio paladino.
Inoltre, Maggi analizza come Trump abbia offerto al suo Paese, stanco del politicamente corretto, valori di sicurezza, ritorno alla prosperità e orgoglio nazionale. Che sono gli stessi in cui un crescente numero di elettori europei si identifica e che desidera che diventino gli assi portanti di una nuova prospettiva politica. Ma anche i contenuti programmatici, che Trump intende realizzare, vanno seriamente presi in considerazione per la politica europea. Come Trump, i leader europei dovrebbero dare maggiore enfasi agli interessi nazionali, soprattutto in tempi di crisi economica. In aggiunta, l’approccio di Trump ai dazi e agli accordi commerciali può offrire spunti su come proteggere le industrie locali e negoziare accordi più favorevoli. Senza trascurare il fatto che la gestione della sicurezza e dell’immigrazione è un tema centrale anche per l’Europa, specialmente in relazione alle politiche di tutela dei confini. Infine, pure in Europa dobbiamo essere ben consapevoli del fatto che investire nella produzione interna di energia è essenziale per ridurre la dipendenza energetica e stimolare l’economia.
In conclusione, Donald Trump abbina uno stile comunicativo originale e spiazzante a una piattaforma programmatica molto più solida e razionale di quanto può sembrare a prima vista. Da cui l’importanza, anche per la politica italiana, di capire l’uomo, il suo stile e le ragioni profonde che hanno portato alla sua rielezione.